Menu
Abbazia di Praglia – Via Abbazia di Praglia, 16 – 35037 Teolo (PD)
Privacy Policy / Abbazia di Praglia © 2024 / Tutti i diritti riservati
“Nella comunità ognuno conservi il posto che gli spetta secondo la data del suo ingresso o l’esemplarità della sua condotta o la volontà dell’abate. … Dunque i monaci si succedano nel bacio di pace e nella comunione, nell’intonare i salmi e nei posti in coro, secondo l’ordine stabilito dall’abate o a essi spettante. E in nessuna occasione l’età costituisca un criterio distintivo o pregiudizievole per stabilire i posti, perché Samuele e Daniele, quando erano ancora fanciulli, giudicarono gli anziani.”
San Benedetto (RB, 63)
La Comunità Benedettina di Praglia è attualmente la più numerosa d’Italia (comunità maschile) e conta circai 40 membri.
La maggior parte dei monaci vive stabilmente a Praglia mentre alcuni di essi vivono nelle tre case dipendenti (San Giorgio Maggiore di Venezia, Monte della Madonna di Teolo, Sadhu Benedict Math in Bangladesh).
Attualmente l’Abate è il P.D. Stefano Visintin.

La fondazione dell’Abbazia di San Giorgio Maggiore sull’omonima Isola lagunare, affacciata sul bacino San Marco, risale al 982 d.C. In quell’anno il doge in carica Tribuno Memno, appartenente alla famiglia che possedeva l’intera Isola, decise di donarla al monaco benedettino Giovanni Morosini – che costruì un Monastero adiacente alla preesistente chiesa, divenendone primo Abate. Il prestigio dell’Abbazia sorse ben presto, tanto che divenne uno dei maggiori centri europei in campo teologico, culturale e artistico. Questo primo complesso abbaziale andò però distrutto nel 1223 durante un terremoto, e venne poi più volte riedificato – fino all’imponente e definitivo progetto architettonico affidato all’architetto Andrea Palladio, avviato dagli anni ’60 del Cinquecento. La Basilica da egli concepita venne contestualmente arricchita di numerose e pregevoli opere d’arte, eseguite da Maestri del tenore di Jacopo Tintoretto e suo figlio Domenico, Sebastiano Ricci, Girolamo Campagna, Jacopo e Leandro Bassano, e il fiammingo Albert de Brule.
Alla caduta della Repubblica, nel 1797, il Monastero venne gravemente depredato. Ma la sua importanza era ancora tale che nel 1800 ospitò il Conclave al termine del quale venne eletto papa Pio VII, al secolo Gregorio Barnaba Chiaramonti, monaco benedettino cassinese di Cesena. L’assemblea cardinalizia che decretò la sua nomina non ebbe luogo, come di consuetudine, nella Cappella Sistina di San Pietro – essendo stata Roma occupata dall’esercito francese rivoluzionario prima, e napoletano poi. Ma, su ospitalità austriaca, il collegio cardinalizio si riunì presso una delle Cappelle private del Monastero che, a seguito del prestigioso evento, acquisì la denominazione con cui oggi è meglio nota, quella di Cappella del Conclave. È ancora oggi possibile ammirare, sui seggi del Coro, i nomi dei 36 cardinali elettori.
Nel 1806 il Monastero venne soppresso dalle leggi napoleoniche, e molti dei beni rimasti vennero venduti o rubati. Solamente pochi monaci ottennero di restare per amministrare la Basilica, mentre il Monastero diventava un deposito d’armi. Rimase un presidio militare anche sotto i governi dell’Impero austro-ungarico e del Regno d’Italia, andando incontro a un drammatico deperimento. La Basilica e alcuni ambienti del complesso monastico a essa adiacenti vennero quindi affidati alla Comunità Benedettina dell’Abbazia di Praglia, che li ripopolò nel 1957. Dopo alcuni decenni di autonomia, dal 2007 l’Abbazia di San Giorgio Maggiore è tornata a essere casa dipendente dell’Abbazia di Praglia.
Il Campanile di San Giorgio Maggiore venne interamente ricostruito nel 1791 dal frate somasco bolognese Benedetto Buratti, a seguito del crollo nel 1774 dell’originale torre campanaria quattrocentesca. Oggi comodamente agibile grazie a un ascensore, il Campanile offre un suggestivo panorama sulla città di Venezia e sulla sua Laguna.

Orari di apertura
La Basilica è aperta tutti i giorni:
aprile – ottobre dalle 9:00 alle 19:00
novembre – marzo dalle 9:00 alle 18:00
Orario Sante Messe
Festive ore 11:00 (cantata in gregoriano)
Contatti
Indirizzo: Isola di San Giorgio Maggiore, 2 – 30124 Venezia
Telefono: +39 375 6323595
E-mail: abbazia@abbaziasangiorgio.it
Come arrivare
Vaporetto della linea Actv 2 con fermata San Giorgio in partenza da:
San Zaccaria (durata del viaggio di circa 3 minuti)
Ferrovia (durata del viaggio di circa 45 minuti)
Piazzale Roma (durata del viaggio di circa 40 minuti)
Tronchetto (durata del viaggio di circa 35 minuti)
l Monte della Madonna è noto principalmente per il Santuario mariano che sorge sulla vetta. Antica meta di pellegrinaggi e dimora di uomini alla ricerca di Dio nella preghiera e nella solitudine della vita eremitica. E’ sicuramente uno dei più antichi centri di devozione mariana della diocesi di Padova.
Il primo documento, che attesta l’esistenza della chiesa del Monte, risale all’11 ottobre del 1253; si tratta del testamento di un certo Wirixolo, ricco mercante padovano, che donò alcuni dei suoi beni alla “chiesa Santa Maria del Monte”.
Fu il Papa Giulio II, con la bolla del 15 giugno 1508, affidò ai monaci Benedettini di Praglia la chiesa del Monte.
In chiesa, al centro dell’abside, è posta la statua della Madonna, scolpita in pietra di Avesa (Verona). È di proporzioni leggermente inferiori al naturale. Non si sa con certezza chi ne sia l’autore. Pare che anticamente la Madonna tenesse con la mano destra, rifatta di recente, uno scettro regale. Un’ampia veste e un ricco manto pieghettato policromi, scendono dalle spalle e si ripiegano ai piedi.

L’attuale Monastero, progettato dall’Architetto L. Pavan, è stato costruito in due riprese: il primo lotto ebbe inizio nel settembre 1966 e si concluse nella primavera dell’anno successivo; il secondo corpo della fabbrica monastica venne realizzato negli anni 1972-73.
Il grande salone, destinato a riunioni, sistemato sotto il piano del piazzale del Santuario, è stato ultimato nel 1975.
Le adiacenze del Santuario sono state sistemate negli anni 1966-1975.
Orario Sante Messe
Feriale: 7:30
Festivo : 10:30
Come arrivare
In auto
Da MILANO: Autostrada A4 MILANO-VENEZIA entrare in A31 VALDASTICO e proseguire in direzione di LONGARE, uscita LONGARE-MONTEGALDELLA direzione MONTEGALDELLA-CERVARESE S. CROCE-MONTEMERLO-TEOLO
Da VENEZIA: Autostrada A4 MILANO-VENEZIA uscita PADOVA-OVEST, tangenziale SR 47 direzione PADOVA SUD-BOLOGNA, uscita n. 6 direzione TEOLO
Da BOLOGNA: Autostrada A13 PADOVA-BOLOGNA uscita PADOVA SUD, tangenziale SR 47 direzione PADOVA OVEST-MILANO, uscita n. 6 direzione TEOLO
In treno
Stazione di PADOVA e autobus per TEOLO, VO’, NOVENTA VICENTINA
Il monastero di S. Benedetto (in bengalese: Sadhu Benedict Moth) è un monastero benedettino situato a Maheswarapasha, in provincia di Khulna, nel sud-ovest del Bangladesh. I suoi inizi si rifanno al gennaio 1978, quando un giovane missionario italiano, Carlo Rubini, ed un giovane bengalese, Premanondo Karmaker, decisero di dar avvio alla vita monastica cristiana in Bangladesh.
Dopo dieci anni, trascorsi nell’approfondimento dell’esperienza monastica (sia cristiana che indù), ed in un suo possibile adattamento alla realtà del Paese, fu acquistato un appezzamento di terreno (a Maheswarapasha, che significa ‘Delizia di Dio’), e nel 1989 si diede inizio alla costruzione del piccolo monastero che nel 1990 veniva riconosciuto come monastero dipendente dell’Abbazia di Praglia (Italia).
Come ogni istituzione monastica benedettina il ritmo di vita del monastero segue l’antico detto latino Ora et labora (preghiera e lavoro).
l monastero cerca di offrire, in seno alla chiesa, un suo contributo religioso/culturale attraverso un proprio programma specifico.
IIl frutto più importante di tale impegno è stato la traduzione (dall’ebraico e dal greco) in lingua bengalese della Bibbia (la cosidetta ‘Jubilee Bible’), adottata e pubblicata dalla Conferenza Episcopale del Bangladesh nell’Anno Giubilare 2000; come pure la traduzione della Liturgia delle Ore, contenente un migliaio di testi patristici (pubblicata nel 2004); omelie patristiche per le Domeniche e le Feste liturgiche; musica per salmi e inni; commentari biblici e altri testi. Grazie a questi strumenti anche il lavoro tra i catecumeni ne ha risentito in modo molto positivo. Un’attenzione particolare viene posta al dialogo interreligioso in quanto il Bangladesh è un paese di religione prevalentemente islamica dove risiede anche una significativa minoranza di religione induista.
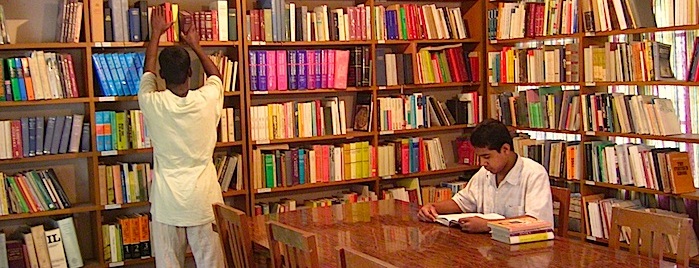

Essendo il Bangladesh un paese povero, l’attività umanitaria caritativa dei monaci è rivolta a quegli strati di società che per vari motivi non possono beneficiare di opportunità generali. (Va da sè che, in questo campo, Musulmani, Indù e Cristiani vengono tutti trattati allo stesso modo).
S. Benedetto vuole che i monaci non vivano di carità ma del frutto del proprio lavoro. Seguendo questa regola, oggi come oggi, mediante la vendita dei prodotti della nostra mini-azienda agricola (ortaggi, latte delle nostre mucche, concime e di tanto in tanto una mucca) la nostra comunità è autosufficiente. Ma non possiamo non vedere le necessità dei poveri che ci circondano, e con le nostre sole forze un aiuto massiccio è impensabile.
La Comunità monastica, accanto ai religiosi residenti, accoglie nel suo ambito anche un “Gruppo oblati secolari” formato attualmente da 32 oblati e da una ventina di “simpatizzanti” che, pur senza aver emesso l’oblazione, partecipano con regolarità alle attività formative del gruppo.
Secondo lo statuto, “l’oblato benedettino secolare è il cristiano, uomo o donna, laico o chierico che, vivendo nel proprio ambiente familiare e sociale, riconosce e accoglie il dono di Dio e la sua chiamata a servirlo… si offre a Dio con l’oblazione, ispirando il proprio cammino di fede ai valori della santa Regola e della tradizione spirituale monastica”.
“L’ammissione all’oblazione è fatta dall’abate, che in ciò esplicita il carisma del discernimento degli spiriti proprio del suo servizio.
Da parte del candidato si richiede il superamento della maggiore età, piena coscienza, congrua formazione e un adeguato periodo di prova, secondo le consuetudini della comunità monastica.
La scheda dell’oblazione viene custodita nell’archivio del monastero, ed è segno del vincolo che unisce l’oblato alla comunità monastica e, attraverso il monastero, a tutto l’Ordine Benedettino” (dallo Statuto degli oblati benedettini).
Attualmente, fanno parte del gruppo oblati del monastero di Praglia, sacerdoti, diaconi, docenti universitari, professionisti, pensionati, casalinghe…, nella maggioranza sposati, alcuni rimasti soli per la morte del coniuge, altri soli per scelta.
Il gruppo si incontra una volta al mese, solitamente di domenica mattina nel “tempo ordinario” e per un’intera giornata di ritiro spirituale in qualche occasione particolare.
Il programma ordinario degli incontri prevede: la preghiera di lodi con la Comunità monastica, una breve lectio sui testi della S. Messa del giorno, una riflessione su un argomento tratto dalla Regola di S. Benedetto, la conclusione con la partecipazione all’eucaristia con la Comunità.

Chi lo desidera può partecipare alla celebrazione dell’Eucaristia e della Liturgia delle ore anche durante la settimana. Prendendo accordi con l’assistente del gruppo o col monaco addetto all’accoglienza degli ospiti, può chiedere di vivere in monastero giornate intere e/o qualche fine settimana di ritiro, scandendo i vari momenti di permanenza secondo gli orari quotidiani dei monaci.
Per informazioni:
Abbazia di Praglia – Via Abbazia di Praglia, 16 – 35037 Teolo (PD)
Privacy Policy / Abbazia di Praglia © 2024 / Tutti i diritti riservati